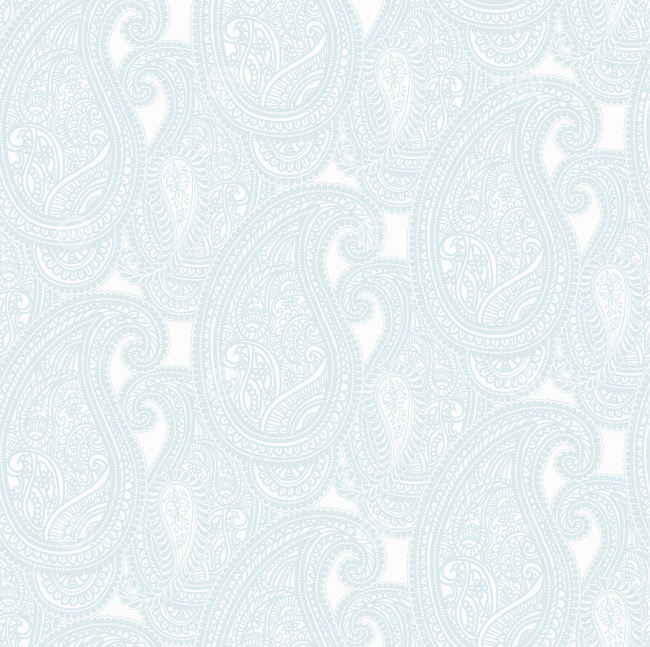Le interazioni con i coetanei hanno grande valore già dall’infanzia, ma i rapporti con i coetanei in adolescenza diventano fondamentali. In piena adolescenza diminuisce il numero di veri amici, si privilegiano i rapporti con pochi coetanei. Si dà importanza crescente agli aspetti psicologici dell’amicizia, in particolare all’autenticità, all’intimità, all’accettazione reciproca e alla condivisione di gusti, valori e aspirazioni.
L’amicizia per i ragazzi e per le ragazze viene vissuta diversamente
Il sesso dell’adolescente differenzia il modo di vivere i rapporti amicali. Per i maschi è importante fare delle attività insieme agli amici, mentre per le femmine è importante scambiarsi confidenze. Le ragazze considerano basilare sentirsi comprese dalle amiche e le loro relazioni sono contraddistinte da maggiore intimità, i ragazzi sono più riservati.
Questa differenza è la conseguenza di stereotipi culturali. I ragazzi tenterebbero a rispecchiare i tratti considerati maschili, quali la prestazione fisica o il bisogno di primeggiare. Le ragazze si riconoscono in tratti psicologici considerati femminili, quali la disponibilità all’ascolto e alla comprensione degli stati d’animo altrui.
I gruppi
Comunemente gli adolescenti si aggregano in “gruppi”. Sono costituiti da un nucleo di coetanei impegnati in una relazione intensa e continuativa, fondata sulla condivisione di esperienze e interessi considerati importanti per il singolo e per il gruppo.
Ogni gruppo definisce i ruoli e le regole interne, chi tiene a esserne membro non può sottrarsi alle norme che lo caratterizzano. Le regole possono riguardare il gergo da utilizzare, il modo di vestire, modalità di condotta che differenziano chi è dentro da chi è escluso. Il contenuto delle regole, gli obiettivi quotidiani e la struttura gerarchica sono influenzati dall’ambiente sociale di appartenenza dei membri.
Il ruolo delle ragazze in gruppi ad alta estrazione sociale è propositivo e critico, al pari dei compagni di sesso maschile. In gruppi di bassa estrazione sociale le femmine appaiono più passive. Le regole del gruppo non sono fissate una volta per tutte, ma possono variare con il subentrare di nuovi membri. Non tutte le norme sociali sono rispettate, i comportamenti considerati appropriati sono definiti in base al contesto e ai valori di riferimento dei membri: ad esempio, per alcuni gruppi, la regola è il mancato rispetto di alcune norme sociali e una condotta socialmente trasgressiva è considerata normale, un membro che non assuma tale comportamento viene visto malevolmente.
Gruppi formali o informali
I gruppi si distinguono in informali o formali, a seconda di alcune caratteristiche che li differenziano:
I gruppi informali sono in genere composti da un numero ristretto di persone, in genere non più di venti. Si formano in modo spontaneo, la coesione tra i membri è data dall’intensità della comunicazione e della relazione. Nei gruppi informali si condivide il tempo libero senza perseguire delle specifiche attività. La costituzione di gruppi informali riguarda adolescenti appartenenti a tutte le classi sociali. Però all’interno del gruppo c’è omogeneità per provenienza, condizione scolastica o lavorativa, look, linguaggio, stile di comportamento. Ogni adolescente si aggrega a coetanei che rispondano alle sue esigenze. Le relazioni tra i membri sono per lo più guidate da caratteristiche di personalità che da ruoli. Essi sono frequentati sia da maschi che da femmine, con una maggiore visibilità dei primi perché le ragazze, in genere, hanno maggiori restrizioni per le loro uscite.
I gruppi formali sono caratterizzati dal perseguire obiettivi specifici. Al loro interno ci sono dei membri adulti con funzione di controllo e di garanti. Nei gruppi formali ci si riferisce a specifici valori e ci si impegna a svolgere delle precise attività, che possono essere sportive, religiose, politiche, culturali.
Un adolescente può far parte di più gruppi formali ed essere membro di un gruppo informale allo stesso tempo. La partecipazione ai gruppi formali è più elevata in giovane età e tende a calare in corrispondenza dei primi anni della scuola superiore. Crescendo, cade infatti l’interesse del giovane per le esperienze aggregative di tipo organizzato per minore coinvolgimento nei valori proposti, per difficoltà nel rapporto con l’educatore o per mancanza di spazi decisionali autonomi.
Come sono composti i gruppi
Un altro fattore che differenzia i gruppi è l’età dei componenti. Nell’infanzia e nella fanciullezza c’è maggior predisposizione a parlare con coetanei dello stesso sesso, questo favorisce la formazione di gruppi di soli maschi o sole femmine. Si instaurano relazioni privilegiate con l’amico o l’amica del cuore. I gruppi informali in genere nascono da un allargamento di un gruppo amicale originario. I gruppi formali già esistenti possono attrarre l’interesse di piccoli gruppi di amici che per paura della novità preferiscono entrarvi insieme. All’interno dei gruppi formali frequentati per molto tempo possono nascere ed evolversi rapporti amicali preferenziali, dando la possibilità ai ragazzi di sperimentare nuovi modi di stare insieme.
Col finire della scuola media e il sorgere dell’esigenza di maggior autonomia, si mettono in crisi le modalità di aggregazione sperimentate in precedenza. In questo periodo si provano modalità alternative di aggregazione, che inizialmente non sono dei veri e propri gruppi informali perché mancano di alcune caratteristiche, quali la regolarità di frequentazione e la continuità nel tempo. Progressivamente, il gruppo dei pari diventa un laboratorio di relazioni sociali, che permette di sperimentare nuovi modi di rapportarsi con gli altri e di entrare in contatto con l’ambiente.
La partecipazione ad un gruppo informale può inizialmente provocare tensioni in famiglia, ma in seguito si trova un adeguato equilibrio.
Verso il mondo degli adulti
Attualmente, la famiglia e il gruppo sono considerati fonti di sostegno complementari per l’inserimento del giovane nel mondo adulto. La famiglia si occupa di guidare il ragazzo nelle scelte che influenzeranno il futuro, quali la scuola, il lavoro o le relazioni sentimentali “serie”. Il gruppo sostiene il ragazzo per i problemi relazionali momentanei (con altri coetanei, con gli insegnanti) e nelle scelte quotidiane. Alla fine dell’adolescenza l’esperienza gruppale perde rilevanza per lasciare spazio al rapporto di coppia e l’aggregazione amicale finalizzata allo stare insieme è meno essenziale con l’avanzare dell’età.